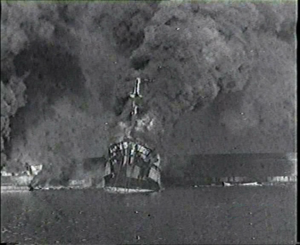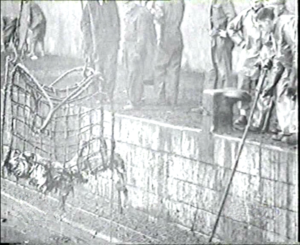Il pomeriggio del 2 Dicembre, un aereo da ricognizione della Luftwaffe, sorvola il cielo di Bari. Il suo compito è quello di fotografare il più possibile: area urbana, porto e aeroporto. All’esperto pilota tedesco, non sfugge il molo di “Levante” pieno di navi all’ancora. L’Autorità portuale è gestita dal Comando Inglese, che ritiene assurdo un attacco della Luftwaffe. Cadono in un Titanico e drammatico errore di valutazione. Infatti alle ore 19:25 provenienti dai Balcani 105 bombardieri sono sulla città. Cominciano a piovere, le famose annunciatrici della morte alata, (milioni di striscioline in stagnola, utili a confondere i sistemi radar ). I fari contraerei del porto, sono già in funzione, subito imitati da quelli dell’aeroporto. La città è quasi incantata, la scenografia è d’autore: il buio della sera è squarciato da una serie di fasci luminosi, che a contatto delle striscioline di stagnola, creano giochi di variopinti colori. Come sottofondo, il cupo rombo dei bombardieri tedeschi, che sganciano le prime bombe sull’area urbana, ma l’obbiettivo sono le 36 navi ancorate. La contraerea è presente e penetra il cielo con i suoi 37mm traccianti. Questi proiettili, sviluppano (Grazie ad una carica di Magnesio inserita in un artifizio sistemato nel codolo della granata) un lungo e colorato percorso. Il cielo è intrinseco di ogni colore. Sul porto precipitano le prime bombe, alcune centrano le navi, altre cadono in mare. Sulle navi colpite cominciano a svilupparsi numerosi incendi che producono enormi colonne di fumo. Ma a sostegno della popolazione interviene un imprevisto e determinante alleato. Il vento, all’improvviso cambia direzione e, spinge verso mare, ma non basta, i rioni adiacenti al porto, sono già invasi dai fumi. Ora il bombardamento diventa intenso, i boati delle esplosioni si susseguono a una velocità inverosimile. Alcune navi bersaglio sono già inclinate su di un fianco. Il Mare a causa della nafta e di altri combustibili è in fiamme e, questo provoca una visione quasi dantesca. In acqua ci sono le zattere dei numerosi equipaggi che dribblano la morte e cercano la vita. Il vento Au menta d’intensità e, costringe i vapori ad allontanarsi dal centro abitato. Nelle acque del porto numerosi marinai sono inghiottiti da vortici infuocati. Alcune navi cariche di ordigni esplodono insieme all’equipaggio. Aumentando di fatto, la drammaticità del momento. I fari sono ancora in funzione, la contraerea balbetta le sue granate antivelivolo e, continua a colorare a suo modo il cielo di Bari. Ma le bombe continuano a piovere e con esse la morte di tanti militari e civili. La città vive momenti di puro sgomento, I baresi capiscono ciò che sta accadendo, ma hanno terrore di quello che sarà. Sono le 19:50, le bombe, precipitano ancora. Una nave esplode, nelle sue stive sono stipate 2000 bombe all’Azoiprite. Molte di queste sono proiettate in alto e, causa l’enorme temperatura, scoppiano lasciando scivolare il potente aggressivo chimico, nelle acque del porto. Nel frattempo, le bombe non scoppiate si sparpagliano nei fondali del porto e, sono tante. L’Azoiprite ormai è mischiata alla nafta incendiata e, il fumo che produce diventa un potentissimo veleno. Bari e, la sua popolazione ringraziano il vento che ha risparmiato alla città una storia più agghiacciante. Le vittime accertate fra militari e civili sono più di 2000. I feriti militari sono soccorsi al Policlinico, gestito dal Comando Neozelandese e, vengono curati in modo superficiale. Anche perché i medici ignorano del tutto il problema Yprite. Tanto che a numerosi marinai è diagnosticata “congiuntivite”. Per i civili non c’è spazio neanche per questi errori e, li lasciano al loro nero destino. Giovanni Lafirenze
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
Presidente Provinciale sezione di Bari
Mi chiamo NACCI Luigi, e sono nato a Bari il 9.12.1941 per cui sono un barese verace considerato le mie radici di baresità “risiedono” nella città vecchia e precisamente in Via S. Bartolomeo n. 2, una strada che all’epoca e attualmente sbocca in Piazza Chiurlia, che a suo tempo veniva chiamata (in dialetto) “Santa Varv”, ossia, in italiano, “Santa Barbara”, e sono il quinto della nidiata di una famiglia numerosa composta da ben nove figli, in sintonia con la norma, non scritta, di quel periodo. I miei genitori, lui commerciante all’ingrosso di frutta e verdura e lei casalinga (con l’hobby della confezione di maglioni e di pullover, fatti a mano con gli uncinetti, nonché nella produzione della pasta locale, orecchiette e cavatelli, che a quei tempi si confezionavano in casa con la collaborazione con sua madre nostra convivente), i quali, senza nulla togliere all’affetto nei riguardi degli altri otto figli (in tutto ne dovevamo essere dodici figli se tre di essi non fossero deceduti in tenerissima età durante l’ultimo conflitto mondiale), stravedevano per me. Allora non capivo bene il perché, pensavo che forse perché, fin da giovanissimo (a distanza di tre anni l’una dall’altra) mi sono capitate alcune disavventure come il sottopormi ad un intervento chirurgico all’ernia inguinale o alla grave scottatura di tutta la spalla causata da una caduta in una pentola di acqua bollente (dovuta alla perdita di equilibrio mentre mi dondolavo su un panchetto vicino ad un pentolone dell’acqua bollente che serviva per cucinare la pasta, la famiglia era composta da ben dodici persone: i miei genitore, noi figli, la nonna, la sorella di questa ed uno zio) per cui questo drastico evento mi costrinse a rimanere a letto per circa tre mesi ed a stare a letto ed a dormire con la pancia in giù, in quanto avevo la spalla terribilmente ustionata. A parte i suddetti incresciosi eventi, la mia vita, fino all’ultima tragica disgrazia, trascorreva tranquilla e serena come quella di tanti altri bimbi della mia età, vivendo senza “grilli” per la testa, tenuto conto che, in quel periodo, non c’erano tanti svaghi o giocattoli come ci sono ai giorni d’oggi. Ci si accontentava di poco ed i giochi erano i più semplici, innocui e senza spese a carico dei nostri genitori. Tutto ciò, come ho detto innanzi, fino all’età di nove anni, due mesi e nove giorni, con precisione, ed esattamente fino alle ore 16,30 circa, di quel fatidico giorno del 18 febbraio 1951, la mia vita trascorreva senza che subissi ulteriori danni fisici. Il 18.02.1951 era di domenica e c’era un meraviglioso sole, tanto da sembrare di essere in estate e non in pieno inverno. Il giorno prima sulla città di Bari si era scatenato un nubifragio tanto da allagare tutte le vie cittadine e, di conseguenza, anche i giardini pubblici ed, in modo particolare, i relativi varchi d’accesso agli stessi. Ma, come ho già accennato, grazie al sole estivo ed al clima primaverile, le strade cittadine si erano prosciugate a tal punto che nessuno più si ricordava della tempesta che si era scatenata 24 ore prima sulla città. Il suddetto giorno avevo indossato, per la prima volta, il maglione nuovo che mia madre aveva terminato di confezionarlo proprio il giorno prima e tutto allegro per il capo di vestiario nuovo, raggiunsi i miei amici nel giardinetto di Largo Adua all’incrocio di via Cognetti e via Abbrescia. Come già detto in precedenza, i nostri svaghi erano semplici, innocui e senza grossi sacrifici economici da parte dei nostri genitori. Uno di questi passatempi, ad esempio, consisteva nel giocare con le foglie che staccavamo dai rami delle siepi che circondavano le aiuole dei giardini pubblici che noi bambini le mettevamo sull’acqua delle pozzanghere per vedere quale di esse era la più veloce delle altre. Se non che io, avendo notato al centro di un cespuglio una foglia grossa e per andare a raccoglierla, mi avventurai sul cornicione di mattoni che recintavano la siepe e nel fare ciò persi l’equilibrio e caddi nella pozzanghera limitrofa alla siepe bagnandomi tutto e sporcando, di conseguenza, il maglione nuovo confezionato con grande amore e sacrificio da mia madre, per cui ritornato a casa dovetti subire, oltre ai suoi rimproveri, anche le sue botte. Inoltre in quel periodo mi stavo preparando per ricevere la prima comunione, per cui al pomeriggio dovevo presentarmi al catechismo per essere interrogato sulla lezione del giorno, pertanto, causa la mia prosopopea di saper tutto e bene e che tale bravura mi avrebbe consentito l’ingresso gratuito al cinema parrocchiale, non mi portai appresso i soldi necessari per acquistare il relativo biglietto per accedere nella sala cinematografica della chiesa dei frati cappuccini, sita tuttora in via Abbrescia. Ma mio malgrado la recita della mia lezione non fu un grande successo, per cui dovetti ritornare a casa, per lasciare il libro del catechismo e prendere i soldi per acquistare il predetto biglietto del cinema. All’epoca abitavo in via Cognetti, di fronte all’attuale cinema Kursaal Santalucia, e casa mia distava dalla chiesa un centinaio metri circa, fra l’andata ed il ritorno dalla parrocchia, ma il breve tragitto non fu sufficiente perchè io arrivassi in tempo per acquistare il biglietto ed accedere nella sala cinematografica. A tale proposito bisogna dire che in parrocchia il film veniva proiettato per due volte e precisamente alle ore sedici per i ragazzi ed alle ore diciannove per gli adulti, per cui una volta chiusa la porta della sala cinematografica non c’era verso di poter entrare. Pertanto ritornai a casa, riconsegnai i soldi a mia nonna e mi faci avere due lire per poter acquistare alcuni gessetti necessari per disegnare per terra una pista ciclistica su cui giocare, insieme ad altri coetanei, al “fantomatico” giro d’Italia, che era un dei giochi preferiti, all’epoca, da noi bambini. Pertanto, con i soldi in tasca, mi avventurai verso la scuola “Balilla”, sita ancora oggi in piazza Carabellese, e dopo aver acquistato detti gessetti presso il chiosco, che stava vicino alla scuola e gestito da una coppia di coniugi anziani, me ne ritornai dai miei amici i quali mi aspettavano nel giardinetto di largo Adua, alfine di disegnare la fantomatica pista ciclistica e giocare al giro d’Italia, usando, per l’occorrenza come “corridori”, i tappi delle varie bottiglie di bibite (aranciate, limonate, chinotto e birre) che raccoglievamo, ogni lunedì mattina, davanti ai bar, prima che venissero scopati dai netturbini. Ma il tragitto di ritorno non fu lo stesso di quello dell’andata, ossia via Abbrescia–Corso Sonnino-scuola Balilla), bensì, pensando di fare prima, imboccai il lungomare Nazario Sauro da Via Giandomenico Petroni. Il fato negativo di quella nefanda giornata era in agguato. Infatti, su questa ultima strada, c’era un tombino del gas scoperchiato ed io ci finii dentro. Poi una volta avviatomi sul lungomare Nazario Sauro in prossimità di via Di Crollalanza, c’era un mio coetaneo, tuttora a me sconosciuto, in quanto lo incontravo per la prima volta, il quale mi invitò ad aiutarlo a staccare un pezzo di gomma che era incastrato in un oggetto metallico dalla forma di un barattolo di salsa di pomodoro. Io, che ho sempre avuto e conservo tuttora lo spirito di altruista (infatti negli ultimi tre anni di vita collegiale mi misi a disposizioni di due compagni di collegio i quali, uno, di origini baresi, era privo delle gambe per essere scivolato, in una serata piovosa, e finito sotto un tram che gli recise le gambe, per cui lo trasportavo a spalle attraverso le scale, quando non si metteva le protesi; l’altro, originario della città dell’Aquila, era privo di avambracci fino al gomito, a seguito di uno scoppio di un ordigno bellico inesploso, per cui lo aiutavo a rifare il letto al mattino ed a indossare e ad abbottonare la camicia (incluso il nodo alla cravatta), la giacca ed il cappotto quando, si andava a passeggio per la città di Torino), presi il suddetto oggetto e mi avvicinai al muro con l’intenzione di picchiarlo sul bordo del cornicione della facciata del palazzo con l’intento di allentarne la presa che bloccava quel pezzo di gomma; ma non feci in tempo ad eseguire tale operazione che quel barattolo, identificato successivamente dalle forze dell’ordine come un ordigno inesploso e residuato bellico, mi scoppiò nella mano destra causandomi i seguenti danni, tuttora evidenti, e precisamente: perdita della predetta mano; perforazione della cornea e del bulbo oculare destro (cecità assoluta da tale occhio), anche se tale danno non è appariscente, tranne per un piccolo strabismo allo stesso organo visivo, e schegge che mi hanno colpito in varie parti del corpo fra cui il ventre, la faccia (per fortuna non molto grave) e gli arti inferiori. Dopo tale disgrazia e dopo aver trascorso quasi tre mesi in ospedale (reparti di chirurgia ed oculistica), mi sono dovuto dare da fare per imparare a scrivere con la mano sinistra, in quanto già scrivevo con la mano destra, nonchè a svolgere tutte le funzioni giornaliere, come il lavarmi con una mano, a vestirmi, etc, etc….
Per fortuna, dopo un anno e mezzo, fui ospitato in uno dei collegi fondati dall’attuale beato Don Carlo Gnocchi (e precisamente a Torino, dove sono rimasto ospite per ben otto anni) il quale agli alpini moribondi durante la ritirata dalla Russia (lui era il loro cappellano) prometteva che si sarebbe interessato dei loro figli; rientrato in Italia, si dette da fare per cercare i figli degli quei alpini deceduti nel vasto territorio russo ai quali aveva dato la sua parola. Ma si rese conto che il numero di detti bambini era esiguo, per cui allargò il suo orizzonte a favore di quei bambini i quali, causa la guerra, erano rimasti mutilati. Pertanto considerato che io appartenevo a quel grosso numero di mutilatini (come ci chiamavano gli abitanti di Torino). Durante quel periodo ho studiato ed ho conseguito un titolo di studio (computista commerciale) e ho imparato molte altre cose (a quelle che già sapevo fare) per la mia autosufficienza, come quella di migliorare la mia scrittura, il saper battere a macchina, l’allacciarmi le stringhe delle scarpe, farmi la barba, farmi il nodo alla cravatta, vestirmi meglio, rifare il letto e molte altre cose. Certo che dopo l’incidente capitatomi il giorno 18 febbraio 1951, ho dovuto faticare non poco per mettermi al passo con gli altri ragazzi, e successivamente con gli uomini (sul posto di lavoro), fisicamente a “posto”; ma non mi sono scoraggiato, anzi, con la mia grande costanza e combattendo molte battaglie, ho superato molte difficoltà, risultando, il più delle volte, vincitore. Ed eccomi qui, all’età ultra 75enne, in pensione, dopo aver lavorato per quasi 40 anni presso il comune di Bari, dove ho dimostrato di essere all’altezza di una persona “fisicamente sana” e di aver sviluppato una carriera amministrativa tanto da raggiungere i posti di comando, e di aver coronato un altro mio sogno scolastico che era quello di conseguire il titolo di studio di ragioniere, considerato che il titolo conseguito in collegio non mi soddisfaceva, per cui ora mi godo in santa pace un po’ di tranquillità. Ecco, per sunto, il racconto della mia storia e di quanto mi è accaduto nella mia vita ed oltre 66 anni fa.
Bari, 18.05.2017 Luigi NACCI


Enzo Varricchio
pubblicato su Realtà Forense, dicembre 2006
Bombardamento di Bari del 1943: dopo la medaglia il mistero resta
Nel 1996 l’unica inchiesta sulle bombe all’iprite, voluta dal giudice Bassi
La città di Bari ha visto riconosciuto dal Presidente della Repubblica l’eroico sacrificio dei suoi cittadini durante gli eventi del 1943. Giustizia è fatta alla memoria. Tuttavia, molti aspetti di quel tragico 2 dicembre, per tanto tempo rimasto ignoto ai libri di storia e ora tornato alla ribalta, restano oscuri.
Mille vittime militari e non meno di 200 vittime civili, sedici navi angloamericane affondate e un ponderoso carico di ordigni colato a picco, non sono stati motivo sufficiente a fare luce su questo misterioso episodio.
Un testimone oculare, il maggiore Glenn Infield, nel saggio pubblicato a New York nel 1971 dal titolo “Disaster at Bari”” lo definì “il più grave episodio di guerra chimica nel secondo conflitto mondiale”.
Per oltre mezzo secolo, “sull’intera vicenda le autorità militari e politiche imposero una censura così radicale, che non soltanto la presenza dell’iprite, ma lo stesso bombardamento tedesco fu cancellato dalla storia” (sono parole di G. Rochat, noto storico militare).
Ancor oggi permangono inquietanti interrogativi cui andrebbe data risposta dopo la concessione dell’onorificenza alla città.
Alcune verità sono ormai emerse nell’ultimo decennio, grazie allo strenuo sforzo dei ricercatori:
i tedeschi, grazie all’attività di spionaggio, vennero informati della presenza delle navi nel porto barese ma, soprattutto della natura del loro carico;
le navi angloamericane, tra le quali la portaerei John Harvey, trasportavano un ingente quantitativo di armi non convenzionali, tra le quali ovuli di iprite, il micidiale gas dall’odore di mostarda, vietato dalle convenzioni internazionali a causa degli effetti devastanti sull’uomo e sull’ambiente;
grazie ad un escamotage, gli aerei tedeschi riuscirono a confondere le postazioni radar e a sferrare l’attacco;
l’attacco fu caratterizzato da una precisione millimetrica: quasi tutte le navi furono affondate con il rispettivo carico di bombe;
Le bombe inesplose furono smaltite in mare per volontà degli americani, con pericoli incalcolabili a tutt’oggi presenti;
un numero imprecisato di baresi fu contaminato dalle esplosioni e riportò in seguito gravi danni;
da quel momento la censura militare, preoccupata delle ripercussioni sull’opinione pubblica, oppose il suo veto alla diffusione di notizie sull’accaduto;
nel primo e secondo dopoguerra numerose persone continuarono a manifestare i postumi di quella contaminazione, come registrato dall’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Bari;
si sono verificati casi di ripescaggio di ordigni da parte dei pescatori, con conseguenze nefaste.
Nel 1994 un ricercatore barese, Angelo Neve, durante una puntata del programma televisivo Combat Film, rivelò che gli ordigni all’iprite erano ancora sui fondali, paventando il deterioramento dei loro contenitori, con effetti devastanti per la salubrità della costa.
Nel 1996, l’allora procuratore aggiunto della Repubblica, Angelo Bassi, aprì un’inchiesta che è rimasta l’unica al riguardo, nonostante le interrogazioni parlamentari che seguirono. Grazie al suo lavoro e alle operazioni condotte dai reparti specializzati delle Forze Armate italiane, si intraprese un’operazione di bonifica del litorale tra Molfetta, Bari e Polignano (vi furono altri affondamenti lungo tutta la costa!), per la cui realizzazione furono stanziati 500 milioni delle vecchie lire, cifra davvero esigua rispetto a quella necessaria per la soluzione definitiva del problema.
Moltissime bombe furono ritrovate e disinnescate e il magistrato riuscì a addirittura a dimostrare che le stive delle navi affondate durante la guerra venivano ancora utilizzate come santabarbare dalla criminalità organizzata.
La Gazzetta del Mezzogiorno del 23 febbraio del 1996 intitolava cubitalmente: “L’ultimo SOS contro l’avanzata criminale viene dal Procuratore Bassi – Misteri e segreti in fondo al mare – Forse la malavita utilizza armi belliche”.
Dopo la prematura scomparsa di Angelo Bassi nel 1998, la questione è finita nel dimenticatoio ma pescatori, sommozzatori e studiosi sono pronti a giurare che le bombe all’iprite ci sono ancora.
Sarebbe, quindi, doveroso da parte del Governo, in occasione del riconoscimento tributato ai cittadini baresi, chiarire questo evento della storia nascosta, risarcendo la città del danno ambientale ed umano subito, le vittime civili o i loro eredi per le sofferenze patite, nonché organizzando una campagna di bonifica che sia risolutiva.
Bari, 19 settembre 2006
Enzo Varricchio
Bombardamento – Bari
2 dicembre 1943
Sui libri di scuola questa data non figura, per la città di Bari fu una giornata indimenticabile ed uno dei più tragici e misteriosi eventi della seconda guerra mondiale (la maggior perdita navale delle forze alleate dopo Pearl Harbour). I radar posti a tutela della città non funzionarono, forse a causa di una semplice astuzia tedesca, lanciare dei pezzetti di carta stagnola per occultarne i sensori elettronici. Sta di fatto che 105 bombardieri Junkers della Luftwaffe, giunti indisturbati, flagellarono per venti minuti il porto ove erano ferme trenta navi da guerra angloamericane che, ufficialmente, trasportavano viveri ed armi convenzionali. Diciassette le navi affondate, 8 semidistrutte, altre danneggiate. Mille i militari morti in una operazione “chirurgica” che uccise cento baresi e danneggiò solo due palazzi. Seicentodiciassette vittime risultarono “contaminate” e i medici notarono strane ustioni sul corpo dei feriti che venivano curati come ustionati e morivano dopo poche ore, mentre un fumo nerissimo continuò a fuoriuscire per giorni dai relitti. Sulla vicenda calò l’oblio del top secret internazionale. In realtà, le navi trasportavano iprite, gas micidiale, vietato dalla Convenzione di Ginevra del 1925 ma utilizzato (clandestinamente) da quasi tutti gli eserciti, durante sia la prima che la seconda grande guerra. I tedeschi, evidentemente, sapevano bene cosa colpire e gli alleati tennero il più stretto riserbo sull’evento, onde evitare che simili barbarie inquinassero il loro mito “buonista” (v. gli studi condotti dall’ufficiale americano John Infield). Anche la memoria storica dei baresi fu confusa artatamente, deviando l’attenzione su successivi episodi di affondamento. Peraltro, gli americani, all’indomani del bombardamento, portarono fuori dal porto alcune navi e le affondarono, lasciando sui fondali molti pericolosi ordigni, individuati tra il 1995 ed il 1996 da un gruppo di studiosi (Angelo Neve, Giorgio Assennato, ai cui lavori si rinvia) e da un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Bari.
Alfredo Castelli ne “Il segreto di S. Nicola” (Ed. Bonelli, 1995) sostiene che il bombordamento servì a coprire una ben più importante operazione teutonica, il trafugamento del Santo Graal (la sacra Coppa nella quale Giuseppe di Arimatea avrebbe raccolto il sangue di Cristo) dalla Basilica nicolaiana ov’era custodito (vedi voce “S. Nicola”). Il tentativo di furto sarebbe fallito ed il Graal si troverebbe ancora a Bari.
Bibl.: Enzo Varricchio, “Nicola e il suo doppio”, ed. dal Sud, 1996.

2/12/’43, a Bari la Pearl Harbour europea
63 anni fa le truppe tedesche della LuftWaffe bombardarono il porto della città
Michele Emiliano durante il seminario dedicato alla strage del 2 dicembre 1943
di Antonio Scotti
02 dicembre 2006 – Sono passati 63 anni da quando l’aviazione tedesca della Luftwaffe bombardò il porto di Bari. Più di 1200 i morti tra militari e civili. Tra le diciassette navi distrutte (stesso numero di Pearl Harbour) figurava anche la John Harvey contenente un carico di iprite, sostanza chimica altamente nociva.
Un anno disgraziato se soltanto si pensa che tre mesi prima le truppe tedesche cercarono di occupare la città e che i cittadini del borgo antico si improvvisarono militari pur di resistere all’invasione delle truppe hilteriane. Per anni il sacrificio dei baresi è stato rimosso dalle memoria storica della nazione. E solo tre mesi fa l’attuale presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha riconosciuto la medaglia d’oro al valore civile a Bari per i suoi numerosi atti di resistenza: l’eccidio di venti manifestanti durante la strage del 28 luglio in via Nicola Dell’Arca (sempre nel ’43); la battaglia del 9 settembre ed infine il bombardamento del porto del 2 dicembre. L’attacco della Luftwaffe fu uno dei più nefasti dell’intera guerra. L’iprite non solo inquinò il mare, ma mise in ginocchio la vita di tutti i giorni dei baresi. Talmente disastroso che il generale americano Eisenhower avrebbe poi scritto nelle sue memorie: “Subimmo la più grave perdita inflittaci da attacco aereo dell’intera campagna del Mediterraneo e in Europa” . Proprio sulle conseguenze di quell’attacco, ieri, è stato organizzato dall’Ipsaic (Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea) un seminario cui sono intervenuti il sindaco Michele Emiliano, il Rettore Corrado Petrocelli, Giorgio Assennato (docente di medicina interna) ed altri studiosi pugliesi dell’ateneo barese.
L’iprite era stata messa al bando dalla convenzione di Ginevra fin dal 1925. Ma gli americani non rinunciarono alla possibilità di dotarsi di questa sostanza durante la seconda guerra mondiale. Il suo nome deriva dalla cittadina belga di Ypres, dove venne impiegato per la prima volta dagli Imperi Centrali nella Grande Guerra. Disgrazia ha voluto che la John Harvey fosse stata ormeggiata dalla marina americana nel porto di Bari.L’obiettivo era quello di scaricare le bombe nel corso della mattinata successiva.
Una volta colpita, la John Harvey esplose in pochi minuti con tutto il suo carico e tutti gli uomini che fin da subito cercarono di domare le fiamme. Un gas tossico e vescicante dal caratteristico odore di senape putrida si diffuse per tutta la zona vicina al porto. Chi decise di buttarsi in mare per raccogliere i naufraghi, entrò subito in contatto con la sostanza velenosa. Questa contagiò i polmoni e molti persero la vita dopo nemmeno un mese dall’accaduto.
Dei 617 intossicati da iprite, 84 morirono a Bari. Sulle ascelle e i genitali l’iprite provocò il distacco della pelle. Molti furono curati con i sulfamidici, ma in pochi casi la cura produsse buoni effetti.
Ciò che certo è che la bonifica dall’iprite fu svolta dai marinai, pescatori e dal personale portuale di Bari. “Persone sconosciute, ma a cui Bari dovrà essere sempre riconoscente per quanto hanno fatto per la città – ha ricordato il sindaco Michele Emiliano – Con loro il porto ha presto ripreso ad esercitare la sua attività commerciale che all’epoca, come oggi, rappresentava un fonte economica vitale per Bari”.
Sebbene i disastri dell’iprite si protrassero nel tempo sacrificando la vita di molte persone, gli studi epidemiologici dell’epoca hanno rappresentato una fonte preziosa per le successive ricerche mediche. “Tutte le riviste mondiali del settore – ha ricordato Assennato- riconoscono che dal monitoraggio delle conseguenze dell’iprite, a Bari si è potuto intraprendere un percorso importante per gli studi epidemiologici. Questi hanno portato alla chemioterapia per la cura dei tumori”.
Molte abitazioni crollarono a causa dello scoppio della Harvey. Una di questa ha lasciato una traccia a fianco della sagrestia della Cattedrale. Mentre nella città nuova crollarono tre edifici tra via Andrea e Roberto da Bari. San Nicola, narranno i pochi sopravissuti, protesse la città scongiurando che l’intera nube provocata dall’esplosione delle bombe potesse diffondersi in maniera completa all’interno del borgo antico. Buona parte della nube, infatti, si spostò verso il mare e la città da 63 anni ricorda il suo patrono con devozione.
Oggi al porto ci sarà la deposizione di una corona sulla lapide che ricorda le vittime di quella strage. Nella sala del consiglio comunale, seguirà una riflessione sul conferimento della medaglia d’oro al valore civile alla città di Bari, a ricordo delle vittime baresi dal 28 luglio 1943 al 9 aprile 1945.
2 dicembre 1943: il disastro di Bari Brucia ancora quel ricordo. Dopo sessant’anni tornano alla memoria i fragori delle bombe che sentivo cadere, immobilizzato dalla paura nel rifugio antiaereo. Ero entrato in seminario a Bari a settembre del 1943. Il 2 dicembre aerei tedeschi della Luftwaffe piombarono sulla città e fu morte e distruzione. Un disastro epocale. Stavamo ancora studiando al terzo piano del seminario, nella camerata San Sabino, mancava poco alla cena, una mezz’oretta alle otto di sera. La serata era tiepida. Ammiravo il profilo dei tetti della vecchia Bari e la sagoma tozza della Cattedrale sotto il cielo stellato. Rombi cupi di aerei a bassa quota per qualche minuto ruppero il silenzio fra le lame dei riflettori antiaerei che scrutavano il cielo in difesa della città. L’ombra di un aereo sfrecciò veloce dinanzi ai nostri occhi, volava radente sulla città. |
||||
|
Domenico Notarangelo
|
||||
La tragedia della famiglia De Bellis
Collezione Angelillo – Donvito
L’aspetto più drammatico delle guerre del Novecento è stato il progressivo coinvolgimento della popolazione civile nelle vicende belliche, con conseguente aumento del numero complessivo delle vittime. Se infatti, ancora negli anni delle guerre napoleoniche, poteva accadere che la belligeranza non coinvolgesse direttamente la vita dei cittadini non coscritti o non arruolati, dalla Grande Guerra in poi ciò è diventato pressoché impossibile, cosicché, come giustamente fa notare E. Hobsbawn, un romanziere che avesse voluto ambientare la sua trama in una qualsiasi città europea degli anni 1914-18, non avrebbe in alcun modo potuto ignorare lo svolgersi del conflitto (Cfr. IL SECOLO BREVE, Arti Grafiche, Bergamo, 1997, pag. 60). E infatti, nel passare in rassegna i nomi dei morti delle guerre mondiali, si riscontra purtroppo un gran numero di civili, vittime dei bombardamenti, delle carestie ma anche degli stupri e dei turpi piani di pulizia etnica.
Fra costoro va annoverata anche una sfortunata famiglia gioiese, i De Bellis, periti nell’incursione aerea compiuta dall’aviazione germanica su Bari la sera del 2 dicembre 1943, episodio non noto ai più anche se di notevole importanza. Il quadro storico in cui si colloca è assai complesso. Sono i mesi successivi all’armistizio, dichiarato ufficialmente nel tardo pomeriggio dell’8 settembre 1943 dal capo del governo, Maresciallo Badoglio. L’Italia era divisa in due: una gran parte del Mezzogiorno era libera, mentre il resto del Paese si trovava sotto il controllo della Germania e della Repubblica di Salò. Bari ricadeva nell’area conquistata dagli alleati e godeva quindi di una relativa libertà: difatti qui si svolse poco meno di due mesi dopo, precisamente il 28 e 29 gennaio 1944, il primo congresso del Comitato di Liberazione Nazionale, ove si prese la decisione di indire un referendum, una volta cessate le ostilità, per stabilire il futuro assetto istituzionale dello Stato; qui rinacquero la stampa e la radio libere; qui si compirono, insomma, alcuni dei passi decisivi verso la formazione della Repubblica italiana. Ma qui vi era pure un porto di discreta rilevanza strategica, ove in quei mesi erano attraccate numerose navi alleate, delle quali almeno una, la “John Harvey”, disponeva di un ingente quantitativo di iprite, un gas tossico adoperato dai tedeschi già nel corso della prima guerra mondiale, nella città francese di Ypres (da cui il nome). Fu proprio questa unità il bersaglio principale dell’operazione militare, i cui effetti furono disastrosi: come riferì un testimone diretto, il marinaio Zanchi, “il deposito della nave [la Harvey] saltò in aria; […] quella fu una notte apocalittica per tutta la città di Bari. Lo specchio di mare del porto e dell’avanporto fu letteralmente invaso dalle fiamme. […] Molte vittime furono lamentate anche tra la popolazione civile, proprio a causa dei gas sprigionati” (questa e altre testimonianze sono riportate sul sito www.prevato.it). Difatti la micidiale miscela gassosa che ne scaturì invase dapprima la città vecchia, poi il territorio circostante, provocando numerosi decessi che si aggiunsero a quelli causati direttamente dal bombardamento: alla fine si contarono circa 1.500 vittime. Per quanto riguarda il naviglio, le navi statunitensi affondate furono 17, 8 quelle seriamente danneggiate, ma anche alcune unità navali italiane furono messe fuori uso, tra cui la celebre motonave “Barletta”. Le possibilità operative del porto risultarono, inoltre, pesantemente compromesse per almeno tre settimane (Ibidem). Per gli alleati le perdite si rivelarono dunque assai gravi, inferiori solo a quelle patite durante l’attacco a Pearl Harbor, ma se si considerano gli effetti, anche sul lungo periodo, dell’invasione della nube tossica in città, l’episodio assume una gravità ancora maggiore, tanto da far guadagnare al capoluogo pugliese il triste primato di maggior teatro di guerra chimica del secondo conflitto mondiale. Ciononostante, il governo di Washington non volle ammetterne la reale portata, anche perché – così si disse – non intenzionato a rivelare il possibile imminente impiego di potenti armi chimiche sul suolo italiano (sull’argomento cfr. anche D. Notarangelo, 2 DICEMBRE 1943, IL DISASTRO AEREO SU BARI, La Piazza, Sammichele, n. 1 del 2004).
Tra i civili caduti, come si è detto, anche i componenti di una famiglia originaria di Gioia: la signora Nietta De Bellis, di anni 43, e i figli Lia, di anni 18, Angelo, di anni 15, Stellina, di anni 5, e Gennarino di anni 4, che attualmente riposano nel piano interrato del cimitero monumentale di Gioia: i loro loculi difficilmente passano inosservati, in quanto disposti in maniera particolare, a mo’ di croce, completata dall’urna dell’unico scampato alla tragedia, il padre Vito, morto nel 1978.
Ma il numero dei civili gioiesi periti durante il conflitto avrebbe potuto essere ben più pesante se, la notte tra il 25 e il 26 giugno dello stesso anno, gli aerei anglo-americani avessero bombardato Gioia e non Sannicandro, come invece avvenne. Il penoso bilancio finale ammontò a 87 vittime, una vera catastrofe per una cittadina che fino a quel momento, come racconta V.U. Celiberti, aveva conosciuto la guerra solo in modo indiretto, essendo rimasta “ai margini della storia” (Cit. DA MONTE SANNACE A GIOIA – STORIA DI DUE CITTA’, Editrice Tipografica, 2002, pag. 363). A lungo si è ritenuto che il vero obiettivo dell’attacco fosse l’aeroporto di Gioia, non individuato dai bombardieri forse perché coperto, quella sera, dalla nebbia. Dello stesso avviso furono i cittadini gioiesi, i quali sentirono tanto il rumore degli aerei quanto il suono della sirena che annunciava il bombardamento, ma quando poi uscirono dal rifugio e videro le loro case intatte pensarono ad un miracolo, oppure ad un tragico anche se propizio, almeno per loro, “scambio di campanile”. Tuttavia più di recente questa ipotesi è stata scartata poiché si ritiene che l’aerostazione potesse servire agli alleati, che proprio in quelle settimane stavano conquistando le estreme propaggini meridionali della penisola, sia per i rifornimenti logistici sia per le partenze dei bombardieri. Più verosimile sembra l’ipotesi che l’errore si sia verificato, ma che a beneficiarne sia stata Santeramo, sede di una polveriera, e non Gioia (Ivi, pag. 373).
Oltre a quanto detto in precedenza, va aggiunto che altresì nel nostro comune e in tutta la provincia non mancarono scontri, anche piuttosto cruenti, tra le truppe tedesche e le improvvisate ma valide formazioni partigiane locali, nei giorni immediatamente successivi all’armistizio: l’episodio più drammatico in proposito fu la fucilazione di undici guardie municipali e due netturbini a Barletta il 12 settembre 1943.
I drammi non terminarono, purtroppo, dopo il dicembre del ’43, ma il pesante e ingiusto sacrificio della famiglia De Bellis resta unico nella sua inconsueta gravità, e rappresenta una sorta di versione civile di “salvate il soldato Ryan”, anche se in questo caso nessun generale magnanimo avrebbe potuto ritirare il solo superstite di quella famiglia dal fronte, perché il teatro della guerra per ogni cittadino non era più solo la trincea, come era accaduto in genere in passato, ma la propria città, la propria strada, la propria casa.
Questa tremenda trasformazione derivava principalmente dall’impiego dell’aviazione come mezzo di guerra, un mezzo che se poteva contribuire a limitare le perdite fra le forze di chi attaccava, aumentava inevitabilmente quelle di chi subiva. Eppure, a dispetto di questa ovvia considerazione, negli ultimi anni qualcuno ha coniato la paradossale espressione di “bombardamento umanitario”, contro la quale sembrano calzanti le parole pronunciate dallo stratega Townshend nel 1921: “in considerazione delle accuse di barbarie rivolte agli attacchi aerei sarebbe opportuno pensare a salvare le apparenze, formulando regole più blande e limitandoli, formalmente, agli obiettivi di carattere strettamente militare […], per evitare di porre in luce la verità che la guerra aerea ha reso obsolete e impossibili siffatte restrizioni” (rip. in E. Hobsbawn, OP. CIT., pag. 33).
Domenico Paradiso
Mistero sul bombardamento di Bari del 1943
Autore Gabriele ZAFFIRI
martedì 04 dicembre 2007
Che cosa ci fu dietro il bombardamento tedesco del porto di Bari nel dicembre del 1943? E quello che vedremo nella disamina di questo articolo.
Nel corso della seconda guerra mondiale i porti di Bari e Taranto erano considerati dalle forze alleate due fra i più attivi e strategicamente importanti porti di tutto il mezzogiorno italiano, anche per il cospicuo numero di mezzi e navi che i porti delle due città custodirono per tutta la durata del conflitto. Ambedue gli attracchi tuttavia furono teatro di diversi disastri navali e misteriosi scenari bellici che, come spesso accade, penalizzarono soprattutto la popolazione locale. Bari visse due pesanti disastri navali, tra i quali il secondo fu fra i più disastrosi di tutta la guerra.
Il primo colpì la città pugliese il 9 aprile 1943 alle 11.57, allorché il piroscafo americano ”Charles Henderson” esplose a causa di un incidente con il carico di materiale bellico. Pesante fu il tributo in vite umane. I morti (accertati), fra gli abitanti del vicino borgo antico e gli scaricatori del porto, furono 175 con 142 dispersi. In totale 317 persone furono travolte e uccise dalla devastante deflagrazione. Più di 600 i feriti gravi, migliaia in modo lieve. Un centinaio le vittime tra gli alleati.
Oltretutto l’esplosione che investì tutto il borgo antico, provocò pesanti danni alla Cattedrale, alla Basilica di San Nicola e alla Chiesa russa.
Ma disastro ancor più grave fu quello che patì Bari il 2 dicembre 1943, a pochi mesi dall’esplosione della nave
”Henderson”. Il porto di Bari in cui erano ormeggiate decine di navi alleate, subì un pesantissimo bombardamento aereo, organizzato dalla ”Luftwaffe”, l’aeronautica militare tedesca. Dopo un volo di ricognizione di un Me.210 pilotato dal tenente Werner Hahn sul porto di Bari ad una quota di 23.000 piedi, alle 19.25 di quel giorno una vera pioggia di ordigni furono sganciati da 105 bombardieri Ju-88 Junker della 2^ Luftflotte del Feldmaresciallo Wolfram von Richtofen, il cugino del famoso “barone rosso” della 1^ guerra mondiale, investendo le navi del porto che si concentravano compatte presso il molo foraneo. Non una bomba mancò l’obbiettivo in virtù del forte assembramento di mezzi. L’attacco sarà una vera sorpresa per il comando alleato. Le navi affondate furono 17, di cui 5 statunitensi, 5 inglesi, 3 norvegesi, 2 italiane e 2 polacche, e 7 furono le danneggiate, di cui 2 statunitensi, 2 inglesi, 1 italiana, 1 norvegese e 1 olandese. Tra le navi affondate vi era la statunitense ”John Harvey” carica di bombe all’ iprite. Il numero di vittime non è mai stato accertato; i morti ammonterebbero a circa 1.000 tra militari e marinai, mentre i feriti ammonteranno a 800 persone.
Ben 628 persone soffriranno tra immense atrocità prodotte dall’ iprite, e 69 persone moriranno nelle due settimane successive all’attacco, e nei loro referti medici [oggi declassificati], su esplicite pressioni di Winston Churchill, verrà scritto:”Morti a seguito di ustioni dovute ad azione nemica”. Il porto di Bari verrà chiuso per tre settimane. Per la gravità del disastro, quello di Bari è conosciuto come il peggior disastro navale della seconda guerra mondiale dopo l’attacco di Pearl Harbor in cui le navi demolite furono parimenti 17.
L’evento rimasto segretato, anche se notizie in merito circolavano già dalla fine del conflitto, riguarda un carico segreto che aveva nelle stive la nave statunitense “John Harvey”: trasportava un carico di 2.000 bombe M47A1 all’iprite [quasi 10 tonnellate], un gas proibito dal trattato di Ginevra.
Navi distrutte (per un totale di 76.936 tonn.):
* John Harvey (US Liberty, 7177 gt)
* John L. Motley (US Liberty, 7176 gt)
* John Bascom (US Liberty, 7176 gt)
* Joseph Wheeler (US Liberty, 7176 gt)
* Samuel J. Tilden (US Liberty, 7176 gt)
Ricordi di Guerra
A cura di Angela Marzella
Ciò che mi sconvolge al giorno d’oggi è notare come si possano vedere immagini di guerra, morti, invalidi, bombe, distruzioni, soprusi con una indifferenza indicibile, mentre si sorseggia magari un buon caffè sdraiati su una comoda poltrona. Sono passati molti anni, ma ancora adesso non riesco a vedere un filmato o un documentario, o una cattiva notizia al telegiornale senza che una stretta non mi attanagli il cuore e mi faccia lacrimare. Per fortuna episodi della mia infanzia, vissuta questa nel periodo bellico, sono diventati così ovattati da smorzare quel dolore intenso che mi provocavano. Posso cominciare da ciò che per molti può sembrare banale, ma che per un genitore e una figlia diventa tragedia. Mio padre partì per la guerra, rimase in Albania, Grecia, poi prigioniero a Milano, oltre la linea Gotica, ritornò per fortuna mia e sua, ma io già seienne lo appellai dicendo “chi sei tu” “vattene, non ti conosco..” Questo fa la guerra: distrugge le famiglie di coloro che non l’hanno dichiarata.
Ripenso al giorno in cui scoppiò al porto di Bari la nave. Ho ricordi nitidi non degli avvenimenti bellici, s’intende, perché piccola, ma del luogo in cui mi trovavo e delle azioni che facevo. Ero con la nonna per strada, fortuna volle a chilometri di distanza, e notai il cielo nerissimo con nuvoloni enormi; per il boato mi ero aggrappata al sottanone della nonna e proseguii la strada insieme a lei di gran corsa nascosta sotto il suo lungo soprabito.
A sera notai casa diversa dal solito. Eravamo in quattro, io con mamma e i due nonni paterni a vivere in quella casa enorme in periferia, (ora inesistente perché in seguito anche eliminata dal Comune poiché doveva essere sostituita insieme a tante altre da quell’ arteria col ponte che dall’hotel Ambasciatori porta a Japigia ), che per grazia del Cielo nonno aveva voluto fabbricare lontano dal centro abitato. Ma quel giorno contrariamente al solito cominciò ad affollarsi di gente. Erano parenti? Buh, non li conoscevo, ma tutti erano conosciuti dai nonni. Andai a dormire, ma ricordo che quando al mattino cercai di raggiungere il bagno dovetti muovermi tra una massa enorme di materassi posti per terra e tra gente che dormiva in ogni dove. Non si notava più un mattone libero. Erano gli sfollati che avevano avuto le loro case distrutte o pericolanti nei pressi del porto.
Nei giorni successivi anche il rifugio era invaso da gente. Era curioso il nostro rifugio personale; sembrava di stare sottoterra nella tana delle talpe. Nonno l’aveva fatto costruire nel centro del giardino della nostra casa. Chiunque entrava non poteva notare fra gli alberi e le piante una botola mimetizzata che appariva come piantagione. Attraverso quell’apertura si scendeva. Si notavano degli scalini scavati nella terra, dopo si accedeva ad una galleria in cui io sgambettavo beatamente e giocavo anche, mentre tutte le persone entrando erano costrette a curvare la spalla; lo so perché sentivo ogni volta il loro respiro sulla testa. La galleria non aveva il soffitto alto e neppure doveva essere larga perché ricordo che c’erano lateralmente dei lunghi sedili sempre ottenuti scavando nel terreno. Quando le persone si sedevano da una parte e l’altra le loro ginocchia quasi si toccavano.
In una delle tante incursioni aeree io bambina dormivo nel lettino. La sirena avvisava di correre ai ripari. Qualcuno della famiglia consigliò di lasciarmi dormire tranquilla invece di portarmi nel rifugio. Mamma rispose, così mi raccontava : “ Dormiente o sveglia, deve stare con me”. Mi portarono addormentata nel rifugio. Nel risalire videro il letto su cui avrei dovuto essere pieno di tutti i vetri rotti della finestra accanto! Viva per miracolo e per intuizione di madre. Curiosamente, quel buio pesto del rifugio, illuminato solo a volte da qualche sporadica candela, mi piaceva.
Non mi faceva paura. Difatti il vicinato si meravigliava di questa bimba che percorreva metri e metri di giardino nella solitudine e nel buio illuminato solo da lucciole e stelle tanto che mi appellavano bonariamente “ Fata Lucia “. E poi bisogna dire che diversi episodi mi capitarono, costringendomi a capire, per fortuna momentaneamente, cosa sia la cecità. Ricordo che un’infezione agli occhi mi costrinse a svegliarmi ogni mattina con tanto pus alle palpebre che rimanevano chiuse e serrate tipo colla. Urlavo al mattino e mamma si precipitava a lavarmi tutte le croste che si erano formate durante la notte. Un’altra volta ancora, mentre ero nei pressi di un passaggio a livello penetrò in un occhio un carboncino prodotto dalla locomotiva. Non so se per mancanza di medici, o di mezzi, o perché io fossi terribile e mi dimenavo tanto quando mi mettevano le mani addosso da non dare la possibilità di farlo ad alcuno, certo è che dovetti aspettare il rientro settimanale di uno zio il sabato successivo perché qualcuno mi ridesse la possibilità di vedere. L’occhio ne fu compromesso per un bel po’. Ed anche quella volta, come in ogni situazione brutta, i ricordi divennero piacevoli, perché una bella azione compensava la brutta: era la nonna che mi portava al mattino, appena sveglia, un po’ d’acqua calda, per “sciacquare le canarile“ ; era il suo modo di dire su qualsiasi bevanda ti proponesse, in quanto sicuramente era il meglio che potesse offrire in quel momento. Si alzava presto al mattino per accendere il fuoco. Il suo volto era spesso sporco di nero perché si passava la mano sporca maldestramente sul viso perché gli occhi le bruciavano per il fumo del carbone o della legna, ma a me piaceva dopo pulirle le macchie col suo stesso fazzolettone.
Era un capolavoro quella donna come aiuto per tutte le madri del vicinato, pronta ad aiutarle quando partorivano, quando si doveva badare ai loro figliuoli, così come era un capolavoro anche per il vicinato quel rifugio personale . Il più vicino, pubblico ed insufficiente, era a km di distanza, in via Pasubio, 41 e noi non avremmo potuto mai arrivarci in tempo oppure ne saremmo rimasti fuori. La scritta con la freccia ed una R è ancora oggi sul muro di una casa in via Alcide De Gasperi, al numero civico 262, poco prima del 272 dove è l’edicola di “Padr ‘eterne” che segnava il confine tra Bari e Carbonara. Il nostro rifugio, ripeto, fu merito del grande mio nonno, ammirato da tutti. Piccolo di statura, molto più basso della nonna (difatti in una foto fu ritratto in piedi vicino alla moglie seduta che manteneva sulle gambe dei bambini), ma un grande uomo. Ripenso ogni tanto alle colazioni fatte con lui… Al mattino pomodori conservati in bottiglia soffritti col peperoncino e pane vecchio delle galline. Sì, perché il pane era razionato; a volte vedevo per casa e non so da dove arrivasse del pane ammuffito che veniva lavato ben bene…e mangiato da noi invece che dalle galline. Per colpa della guerra la nostra bella famiglia benestante, con papà e cinque zii scapoli che apportavano il contributo dei loro stipendi, si era ridotta a quelle quattro anime che erano costrette ad allevare galline, ochette e conigli per poter sopravvivere. E grande fortuna… Almeno noi mangiavamo!
Come ammiravo il nonno! Mi raccontavano che una volta avrebbe dovuto avere la perquisizione in casa da elementi fascisti…Egli aveva compromettenti documenti socialisti.. Lo avvisarono in tempo, raccolse tutto e scappò; rimase per una notte ed un giorno con altri amici su una barca al largo lontano dal porto, per poi rientrare in un’altra casa che per fortuna aveva. Cosa non semplice per i tempi di guerra era anche possedere una radio. Il nonno la faceva apparire miracolosamente in casa all’imbrunire. Dov’era durante il giorno? A sera era tutto un bisbiglio, un sussurro, un ingorgo di suoni striduli, mamma che ripeteva ecco …ecco..ora si sente appena…gira gira…RADIO LONDRA. Era proibito sentire le notizie! Per anni abbiamo conservato anche a guerra finita quel pezzo da museo di radio per poi scoprire, quando l’abbiamo data ad un amatore di Marconi, che era una radio mai vista perché assemblata con i pezzi più vari ed eterogenei! In pratica i miei zii ritornati salvi dalla guerra, o arrivati durante la guerra, non so, avevano fregato i pezzi necessari qua e là, chissà da dove, forse dagli alleati, e l’avevano costruita da soli.
In effetti nei pressi di casa nostra c’era un campo di alleati, dicevano di neo-zelandesi, ubicati alle spalle dell’attuale Svea e Saicaf, tra via Amendola e la ferrovia di Japigia.
Ricordo che passavano con i camion che erano gli unici mezzi motorizzati che vedevamo. Noi si era abituati alle biciclette, a qualche moto, ma per di più ai carri, alle carrozze ed ai cavalli. Una volta fui portata da due militari di cui non capivo il linguaggio e da uno zio che si era inserito come elettricista nel loro accampamento, proprio nella cabina di un camion. Feci una lunga gita …..in pratica pochi chilometri perché si arrivò fino al “macello vecchio” da dove eravamo nei pressi di Mungivacca… ed ebbi anche un bel gelato. Ho ancora chiaro il fazzolettone che mi misero al collo per non farmi sbrodolare!
Ed è curioso il ricordo che ho dell’arrivo degli alleati a Bari. Notammo lontano, sulla vecchia statale 100 (attuale via Amendola, prossimità dell ‘ospedaletto pediatrico Giovanni XXIII) che collegava Taranto a Bari, nuvole all’orizzonte ed un’accozzaglia di oggetti indefiniti. Man mano che si avvicinavano si notava una processione di cose che non avevo mai visto: carri armati, camion carichi di soldati , camionette con militari pieni di mostrine e di armi, cannoni… Io mi trovai lungo il bordo della strada perché con mia nonna ero andata a prendere una cesta d’uva dalla contadina, grappoli stupendi e gustosi. Rimanemmo lì incantate per la visione di questo lunghissimo e stranissimo corteo… A un bel momento infinite mani si sporsero da un camion e la cesta si svuotò dell’uva e si riempì di gallette, cioccolate, caramelle. Ma non sempre le cose erano belle. Una volta scappammo di gran corsa perché la fabbrica “Zanoletti”, posta nelle vicinanze della nostra villa e che produceva gomme, andò in fiamme ed il fuoco persistette per diverso tempo. Non so se fu dolo o bomba. Un’altra volta ricordo che ero con uno zio, zia e mamma verso il lido Marzulli vicino al mare, quando ad un tratto un aereo cominciò a falciare e noi corremmo verso una baracca; a mamma sanguinava una gamba, per fortuna una ferita superficiale.
Una chicca , invece, sull’evasione di papà dalla caserma a Milano. Era lì prigioniero con altri in attesa di deportazione, quando davanti alle sbarre gli si avvicinò una donna che offrì proprio a lui un pacco di sigarette. Nell’interno, arrotolato, un foglio che riportava la mappa della fognatura… In fretta ed in segreto riuscirono ad organizzare la fuga… Dal chiusino si portarono fuori dalla caserma e dalla città. Ogni tanto, arrivati sotto i chiusini stradali, respiravano. Chi si era avventurato dopo, con bagagli vari, rimase per sempre in quella fogna, o anche chi non riusciva a respirare bene, come anche finirono falciati dai colpi dei fucili coloro che erano stati visti sparire lì in fondo dai tedeschi, all’inizio della loro tragica avventura. Papà raccontava che ad un bel momento, nei pressi di un chiusino, trovarono persone che li raccolsero, li lavarono, fecero loro indossare abiti da contadini, e li smistarono immediatamente nelle campagne. Il mio papà, che si chiamava Onofrio, fu ribattezzato col nome di Giacomino e mandato nelle campagne di Caravaggio (provincia di Bergamo). Dopo tanti giorni di digiuno e per le forti esalazioni della fogna non riusciva neppure a mangiare. Un contadino, o forse un militare in incognito o un patriota o chissà chi, gli offrì qualcosa che per la prima volta mio padre vedeva e che continuò a mangiare anche dopo la liberazione: pane e gorgonzola. Diceva che con ciò gli “si apriva lo stomaco..”! A proposito dei mezzi di locomozione, invece, mi piacerebbe sottolineare episodi del dopoguerra. Non si parlava alle bambine e poi future adolescenti di tanti argomenti così detti “impuri “, non pronunciati dai genitori, condannati dalla Chiesa… ed intanto sulla pelle delle fanciulle cadevano tante tegole di tristi esperienze. Le strade a quei tempi non erano asfaltate ed erano percorse da carrettieri che trasportavano materiale pesante, tipo pezzi di tufo, mattoni, tronchi di albero , a volte con tutte le chiome. Nel momento in cui i carri erano vuoti i carrettieri lanciavano i loro cavalli a corsa pazza nel bel mezzo della strada, incutendo paura a quelle poche persone che potevano trovarsi sul ciglio tutto sconnesso e col fosso raccogli acque che allora era presente lungo tutte le strade provinciali. Gli uomini, però, dopo la guerra avevano una fame di sesso terribile, per di più anche la parola pedofilo non era nel gergo quotidiano, né alcuno che lo sapesse lo spiegava. Certo è che due carrettieri su un carro piatto trainato da due cavalli cominciarono ad inseguire me povera novenne che pensava di recarsi a scuola, sola, affrontando tre km circa di strada isolata, deserta. Se correvo facevano aumentare la corsa ai cavalli, se mi fermavo facevano fermare i cavalli impennandoli ed essi poi ridacchiavano bestialmente. Cosa fare? Quello che ho imparato dalla nonna : la difesa del coniglio, cercare spazi piccoli e correre. Difatti corsi in avanti con quanto più fiato avessi, essi mi inseguirono a velocità, improvvisamente mi lanciai nel fosso della carreggiata esattamente al loro contrario e ritornai veloce all’indietro verso la zona da cui provenivo. Se avessero fatto girare cavalli e carro a velocità si sarebbero “accappottati”. Ero salva! Un’altra volta, invece, un tizio era lungo il bordo della strada, accovacciato su un sasso ed appena mi vide a distanza giungere cominciò con manovre che non sapevo distinguere: quando fui nei pressi notai il suo membro di fuori e tanti movimenti di mano… Per fortuna era tanto vecchio ed ubriaco che non ebbe la forza di prendermi e d’ inseguirmi. Ma ciò che mi ha fatto tener vivo l’episodio nella mente fu il fatto che il tale signore vendeva palloncini e giocattolini ai bambini durante le sagre, con una strana ed ampia vetrina di legno piazzata su una bicicletta. Mentre le mamme si informavano sui prezzi, egli accarezzava le bambine e le invogliava a scegliere abbassandosi verso di loro e facendo aumentare quell’antipatica scoliosi laterale che aveva. Ricordo che io, trentenne quasi, lo rividi per la sagra di san Nicola ancora nel suo esercizio, però accompagnato da una donna bruna che sembrava il suo carabiniere personale. Truce ella appariva, forte e per nulla comunicativa… ma per me era una dea! Almeno lo faceva star fermo.
E poiché nei tempi più moderni fui tra le prime donne a prendere la patente, spesso ho sentito dire:” Beata te che non trovavi macchine per la strada”. Ma ci pensate trovarsi sulla parte alta del sottovia Quintino Sella, pendenza 50° circa , dietro un carro piatto trainato da due cavalli che scalpitavano perché gli zoccoli sdrucciolavano sulle basole bagnate di pioggia? Ci voleva capacità e soprattutto coraggio.
Fonte: Archivio di Stato – Bari
Testi consigliati
 |
 |
Disastro a Bari – Glenn B. Infield – Adda editore, Bari 1971
9 aprile 1945 – Esplosione della Charles Henderson

…Ore 11.57 del 9 aprile 1945, una nave carica di munizioni, la Charles Henderson, ancorata presso la banchina 14, del porto di Bari, esplode e provoca la morte di numerosi militari e civili…
Il fronte meridionale in Europa è ancora un fuoco ardente, infatti la 15° Forza Aerea opera su obbiettivi come Verona, Brescia, Bologna, Brennero, ecc…
La 12° Forza aerea nello stesso mese incursiona: Pavia, Voghera, Vigevano, La Spezia, San Benedetto Po, Ostiglia, Piacenza, San Ambrogio di Valpolicella, ecc…
Per ciò dagli Stati Uniti continuano a partire navi cariche d’ogni rifornimento necessario, sia all’aviazione di base in Puglia, quanto per le truppe impegnate, tra le decisive battaglie, del nostro nord nazionale.
Queste moderne navi (Liberty) approdono, nel porto di Bari.
La Charles Henderson incaricata al trasporto di munizioni addette per lo scopo, il 14 marzo del 1945, dal porto di Norfolk, inizia congiuntamente ad altre 45 navi il suo ultimo viaggio.
Per l’Henderson e le altre unità navali alle ore 13 del 29 marzo nascono i primi guai.
Infatti nei pressi dello stretto di Gibilterra il convoglio, patisce un attacco portato a termine da sommergibili tedeschi.
L’Henderson riesce ugualmente a raggiungere prima la Sicilia e, più precisamente il porto d’Augusta.
Dopo una breve sosta per rifornimento l’Henderson giunge a Bari la mattina del 5 aprile, dove ormeggia presso la banchina N. 21.
Per ragioni logistiche è spostata alla banchina N. 16.
All’interno delle proprie stive sono accatastate, 6.675 tonnellate di bombe d’aereo e munizioni varie.
Le operazioni di scarico dell’Henderson, iniziano immediatamente. I marinai sbarcano 2.450 tonnellate di materiale bellico.
Ma la mattina del 9 aprile è inviata alla banchina N. 14.
I lavoranti addetti riprendono immediatamente lo scarico della stiva N. 5, (dove i portuali sgravano la nave d’altre 500 tonnellate di bombe d’aereo). Alle ore 11.57 la nave esplode
Questo breve racconto è tratto dalla brochure scritta in occasione della Cerimonia Commemorativa del 9 aprile 2008, “ Quelli Della Charles Henderson” voluta dall’Autorità Portuale di Bari, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, Regione Puglia, Provincia di Bari e Comune di Bari.
Unica incongruenza storica, la voce: “… Che gli inglesi causano l’esplosione della nave, per paura di un “imminente arrivo delle truppe germaniche…”.
Ma come sappiamo benissimo tutti, in quella data i militari tedeschi sono già stremati ed agonizzanti a difesa della Linea Gotica. Il 17 aprile la forza anglo-americana supera, ogni resistenza e il 21 dello stesso mese libera Bologna.
Ovviamente chi desidera l’opuscolo originale, lo può trovare In questi uffici delle Autorità citate.
Unico dispiacere è constatare come la città di Bari, che ospita Il Sacrario dei Caduti Della Seconda Guerra Mondiale, non ha mai considerato un Monumento visibile da indirizzare nei confronti delle tragedie cittadine. Mi spiego: Non serve una specie di Croce accolta all’interno, dal Cimitero Comunale, obbligatoriamente occultata alla vista di concittadini, scolaresche e turisti.
Ciò, che si richiede, è un solenne Monumento dedicato alle vittime del 2 dicembre 1943 e del 9 aprile 1945, un monito, di marmo e bronzo, verso ogni logica di guerra. I luoghi dove realizzarlo in Città certo, non mancano. Lancio l’idea del nuovo giardino di “…Punta Perotti”.